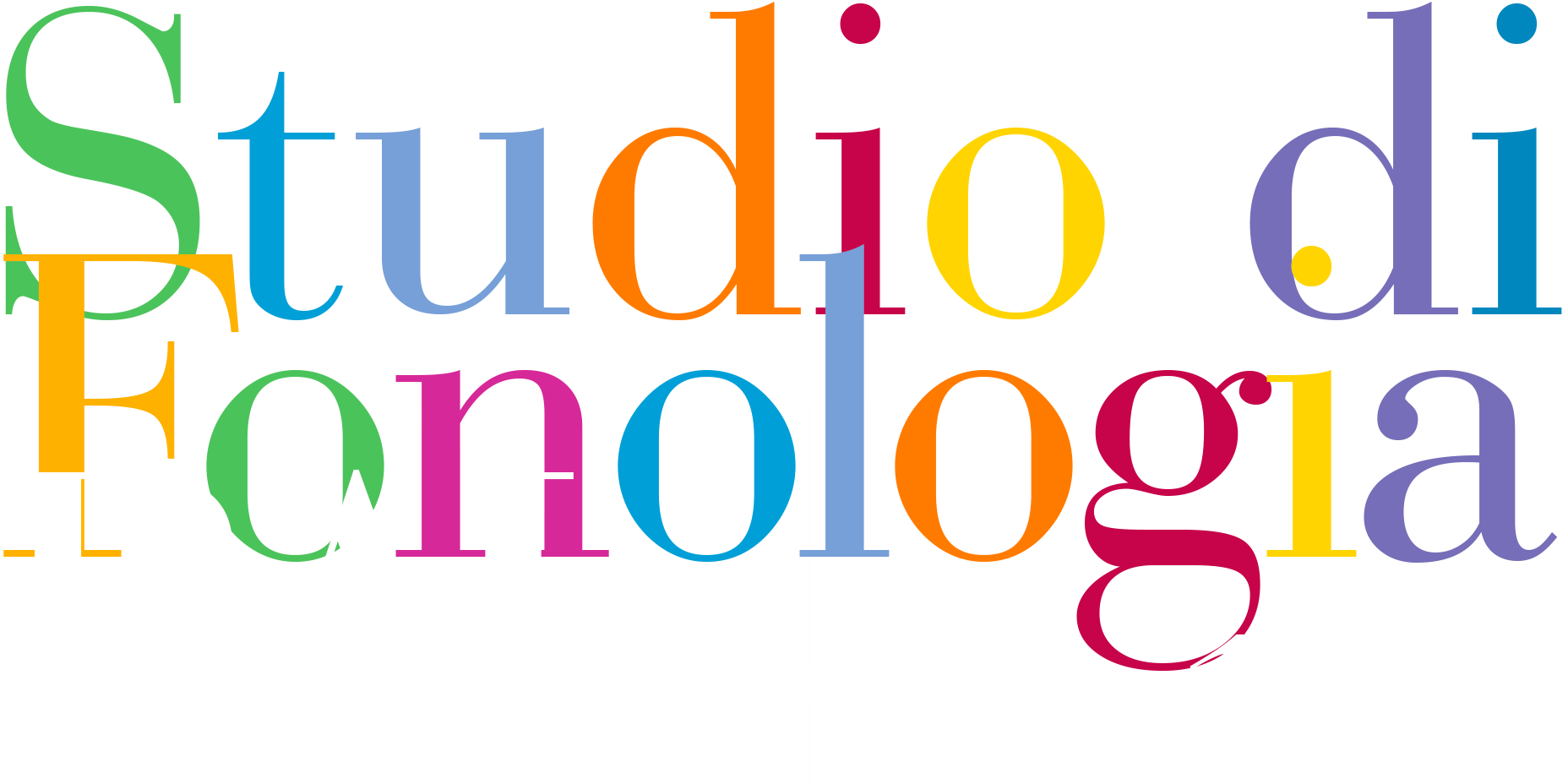

Bruno Maderna
Venezia, 21/04/1920 - Darmstadt (Germania), 13/11/1973
Compositore e direttore d'orchestra
L’infanzia e l’adolescenza di Bruno Maderna sono state caratterizzate da una precocità musicale prodigiosa. Dal 1940, dopo il diploma in composizione, frequenta Malipiero, futuro intermediario per il decisivo incontro con Luigi Nono. Musicista in cui i poli della creazione e dell’esecuzione risultano inseparabili, Maderna accompagnò per l’intera esistenza l’attività compositiva a quella direttoriale. Nel 1948 conosce Scherchen: grazie a lui entra in contatto con il circolo di Darmstadt, frequentandone i corsi e facendo eseguire la sua musica fin dal 1949 (Fantasia e fuga su B.A.C.H.). In questo crocevia d’esperienze e personalità - a contatto con Messiaen, Leibowitz, Boulez, Stockhausen - egli trae nuovi stimoli come compositore e direttore, fino a divenire uno dei protagonisti del rinnovamento musicale del dopoguerra, promotore e sperimentatore delle coeve istanze tecnico-compositive, dalla serialità alla musica elettronica (Musica su due dimensioni, 1952, n.v. 1958; Notturno 1957; Continuo 1958) all’aleatorietà. Nel 1955 fonda con Berio, presso la RAI di Milano, lo Studio di Fonologia Musicale sostenendo inoltre una serie di iniziative votate alla diffusione della nuova musica. Procedimenti costruttivi seriali, elementi della tradizione ed elaborazioni ritmiche convivono nella sua musica in un singolare equilibrio. L’antitesi tra disciplina e un’irrefrenabile tendenza alla libertà conduce, negli anni ’60-’70, al superamento di ogni sistematicità autoimposta in una tecnica per “quadri” indipendenti e componibili, talora a metà tra il collage e l’autocitazione, retti da una chiara logica formale e una rinnovata liricità (Hyperion, opera multiforme in divenire; Quadrivium, 1969; Serenata per un satellite, 1970; Ausstrahlung del 1971; Satyricon, 1971-1973; III Concerto per oboe, 1973).
(Angela Ida De Benedictis)

































